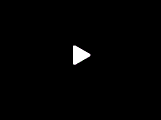2011
.jpg)
I Difensori - Palazzo Steri
Sono nati sempre per caso i temi e i testi delle nostre annuali sacre rappresentazioni in memoria dei martiri della libertà del 23 maggio e del 19 luglio. Nella casualità è sempre rimasto punto fermo, comunque, l’idea dell’amore vincolata in radice all’idea di sacrificio. Che è la cifra della vita e della morte di tutti i caduti sulle strade di Palermo, negli anni della deriva e della mattanza. Verrà certo il giorno in cui ci fermeremo, ma ormai sono più di dieci anni che percorriamo la stessa via e troviamo sulla via giovani compagni di strada che rendono degna questa nostra patria terrena che è dovere di ognuno difendere dagli assalti del male.
Pensando a Palermo, ho sempre pensato all’Iliade. Ho sempre pensato a Palermo come alla città di Troia, assediata dagli Achei, così, per puro piacere di conquista. E ho sempre pensato a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, a Chinnici, a Cassarà, a Giuliano e a tutti i guerrieri caduti nei terribili anni di fine secolo come a tanti Ettore, come a “I Difensori” della loro città assediata. Per i difensori, omericamemte, non c’è alternativa al sacrificio e non c’è limite al loro Amore. Essi combatteranno sempre fino alla morte, che già sanno che verrà, perché sempre più preponderanti sono le forze del male, anche se non sarà loro la vittoria finale. Mancava allora al nostro progetto di ricerca e di vita un testo, una sacra rappresentazione dedicata ai difensori. La sua nascita fu soffertissima e molti eventi concorsero a formare il testo.
Il 16 settembre del 2010, nel pomeriggio, vidi l’impossibile: una bara uscire dal portone centrale della Facoltà di Lettere e Filosofia. Conteneva le spoglie mortali (lo spirito ancora vive tra noi e sempre vivrà come segno del dolore di una generazione intera) di Norman Zarcone, dottorando che aveva posto fine alla sua vita volontariamente per ritrovare quell’infinito che gli era stato negato dalla normalità e banalità della vita, secondo le indicazioni che la sua scrittura aveva lasciato in una sorta di consapevole testamento giustificativo della sua decisione. Norman era stato un mio alunno, lo volli ricordare a un mese dalla morte con una serata nel chiostro dello Steri cui parteciparono amici alunni colleghi, corpo accademico. Per mesi lottammo fino a dedicare nel Polo didattico uno spazio alla memoria di tutti gli studenti che non avevano saputo sopportare lo scarto tra i loro sogni e la realtà, spazio che ebbe nome “Generazione Norman”. L’idea dei Difensori nacque in quei mesi, e poco a poco casualmente prese forma. Innazitutto grazie alla disponibilità di due giovani studentesse, splendide soprano dalla voce l’una struggente (quella di Alessia Acquaviva) l’altra incantevole (quella di Fulvia Lo Cicero), a donare il loro talento alla nuova rappresentazione dedicata a Norman Zarcone. Alessia e Fulvia, sue amiche inseparabili, dettarono la struttura del nuovo testo: loro avrebbero cantato alcune aree da grandi opere liriche, introducendo ogni scena con le loro voci. Così la dimensione de “I Difensori” divenne lirica: mancava solo il testo.
Il canto sesto dell’Iliade, l’incontro tra Ettore e Andromaca, fu il primo testo. Le Porte Scee è non solo il titolo del mio primo libro di versi, ma anche la sintesi perfetta della mia idea sulla vita. Ciascuno non sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole, ma sulle Porte Scee, in compagnia dell’essere amato, sulla soglia che divide (e insieme unisce) la vita e la morte. L’amore stesso vive eternamente solo se consiste su questa soglia e nella sensazione della perdita vive la sua infinità. Ho sempre pensato a donna Agnese Borsellino quando ora leggo le parole di Andromaca e a Paolo Borsellino quando leggo la risposta di Ettore. Se fosse possibile una anatomia dei Difensori, il Corpo sarebbe di certo l’eroe troiano che avrà sempre “onore di pianti” fino quando sarà “santo e lacrimato il sangue per la patria versato”, fino a quando risplenderà il sole “sulle sciagure umane”.
Il secondo testo nacque per caso. Accadde una mattina di febbraio che scrivessi una sorta di inversione del mito di Orfeo e Euridice. Sin dal 1983, anno di pubblicazione per Mursia della mia “Origine orfica della poesia”, questo era stato il mio mito. Dunque intoccabile. La sconfitta del poeta era del tutto evidente in ogni interpretazione critica, anche nella mia. Poi, quella mattina, la sconfitta di Orfeo si mutò nella vittoria di Euridice. Immaginai che fosse morto Orfeo e che Euridice per il suo canto avesse ottenuto di riportarlo vivo dall’Ade. Ma immaginai anche una Euridice immune da curiosità e egoismo, una Euridice che non si volta e che riesce a portare in vita il suo sposo dall’Ade. Questo mio testo ricondusse alla mente subito la storia di Savitri e Satjavati, la storia della sposa del Dharma raccontata nel “Mahabharata” che non si rassegna dinanzi alla morte dello sposo, segue Yama, il dio della morte fino alle sue case e alla fine con straordinari discorsi lo convince a restituirne l’anima. Decisi di tradurre la storia di Savitri solo quando Marco Benigno, giovane di rara energia spirituale, mi chiese di potere interpretare Yama, senza sapere che io lo avevo già deciso. E di interpretare Yama scegliendo la sua Savitri in Luciana Priolo. Poi, accade la bellezza.
Lo spazio magico dell’Atrio dello Steri divenne un giardino. Introdotte dalle voci meravigliose di Fulvia e Alessia ogni scena una sorta di quadro con luci e ombre sapientemente diffuse. Daiana Floria per l’ultima volta fu protagonista vestendo i panni di Andromaca, insieme a Marco Canzoneri, Ettore agitato. Fu grande onore accogliere tra noi una studentessa che già era attrice affermata al Teatro Biondo di Palermo: Aurora Falcone, che insegnò a tutti noi che cosa significhi umiltà, così come una splendida Cassandra interpretata da Virginia Lima, da anni con noi. La prima scena fu, in fondo l’ultima per tanti giovani ormai sulla soglia di nuove responsabilità di vita. Luciana Priolo interpretò una sognante e leggera Euridice insieme al suo Orfeo silenzioso, Piero Di Dia: insieme furono nell’ultima scena scena Savitri e Satjavati. Il possente e oscuro Yama di Marco Benigno resta indimenticabile per potenza espressiva e autenticità: rese viva la Morte per un istante, ma ne svelò anche il volto pietoso. Come se la morte stessa fosse colei che difende la grandezza della Vita dalla banalità della pura conservazione, accettando di essere sconfitta dall’Amore. Cogliemmo, quella sera, i fiori del Bene.
I Difensori - Petralia Sottana - Convento dei Padri Riformati
Prologo
I due coreuti restano tra il pubblico senza musica prima ancora che entrino sulla scena gli altri interpreti
Primo leggi tutto ...